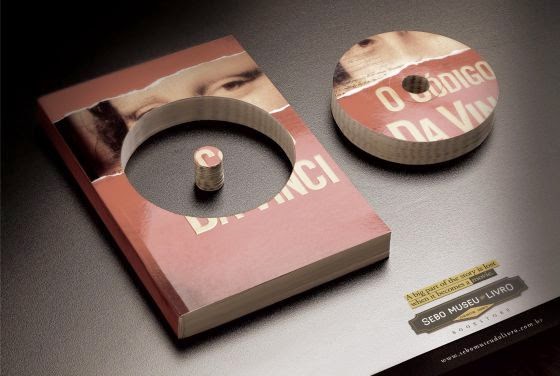Zanarini sul palco di RNext racconta i vagiti del web italiano e fa gli auguri a #Cagliari2019

Zanarini sul palco, io sotto (foto: G. Lecca) Il 10 Luglio, prima che il maestrale mi spazzasse via, sono andato a sentire Pietro Zanarini sul palco allestito in Piazza Palazzo a Cagliari per RNext . Raccontando la storia, non casuale, delle prime iniziative del CRS4, Zanarini ha spiegato chi sono gli innovatori di oggi, i 'nexter': quelli che esplorano nuove strade, a volte partendo da piccoli sentieri, perché sentono che in quella direzione realizzeranno qualcosa di molto interessante, anche se non sanno ancora cosa svilupperanno esattamente. Sono ricercatori e imprenditori che vedono oltre e che sono in grado di connettere tra loro concetti e cose anche già esistenti, in modo nuovo e spesso più semplice di prima. Zanarini ha iniziato dalla storia di Tim Berners-Lee e dalla sua proposta del 1989 di una struttura di informazioni ipertestuali connesse tra loro. Da quell'intuizione si originò il World Wide Web. Zanarini ha poi raccontato la nascita del CRS4: l'ar...