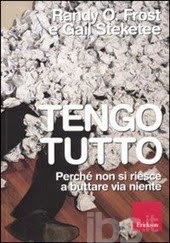Accessibilità Universale ancora lontana: "Design for All" non fa rima con "wheelchair". Marco sfida i marciapiedi di Cagliari (video)

Oggi ho voglia di raccontare qualcosa che non va. Qualcosa che se non la guardi bene, con attenzione, proprio non la vedi. Voglio raccontare le scoperte che ho fatto nei quarantacinque minuti che ho trascorso questa mattina in compagnia di un amico. Scoperte che non necessitano di microscopi, di telescopi, di acceleratori di particelle o di sequenziatori del dna. Basta guardare da vicino i marciapiedi, osservare i gradini che li separano dalle strade, toccare con mano la fatica (e i pericoli) nascosti dietro queste cose. Tutte cose che hanno un nome: barriere architettoniche. "Ma come non le avevano vietate?"... Certo, nelle nuove costruzioni. Ma nei marciapiedi vecchi di 20, 30 o più anni? In quelli le barriere ci possono essere, eccome. Oggi ho fatto un giro a Cagliari (ma il discorso vale per molte altre città) insieme a Marco Girau , un amico di vecchia data che si muove con disinvoltura su Facebook (dove segnala disagi e barriere) ma che nella vita reale deve fare ...