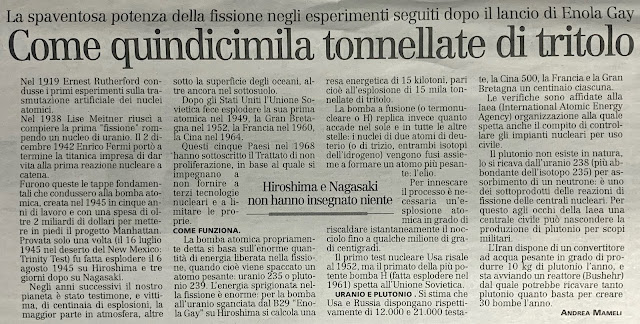Ricerca-innovazione nuove tecnologie offerte all'industria (L’Unione Sarda, 11 marzo 2006)

Ieri, nella splendida cornice di Villa Bellavista, a Monteponi, si è svolta la prima delle due giornate - la seconda sarà a Carbonia il 31 marzo - organizzate dal Promea e dal Consorzio 21 sul tema «Tecniche sperimentali per la caratterizzazione dei materiali: dal laboratorio alla produzione». Ilio Salvadori, Presidente dell'Associazione per l'Università del Sulcis Iglesiente (Ausi) ha inaugurato la giornata di presentazione del distretto tecnologico di scienze dei materiali, energia e georisorse del parco scientifico e tecnologico della sardegna, Polaris. Un caldo sostegno all'iniziativa è venuto dai sindaci di Iglesias e di Carbonia. Il prorettore dell'Università di Cagliari, Adolfo Lai, ha sostenuto l'importanza dell'insediamento universitario a Monteponi come risposta culturale alle necessità di un territorio di antica tradizione mineraria. Il direttore di Polaris Francesco Marcheschi ha sottolineato il ruolo del Consorzio21 come elemento di raccordo tra la ...