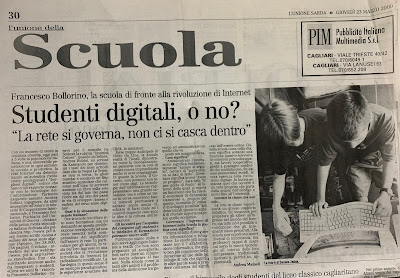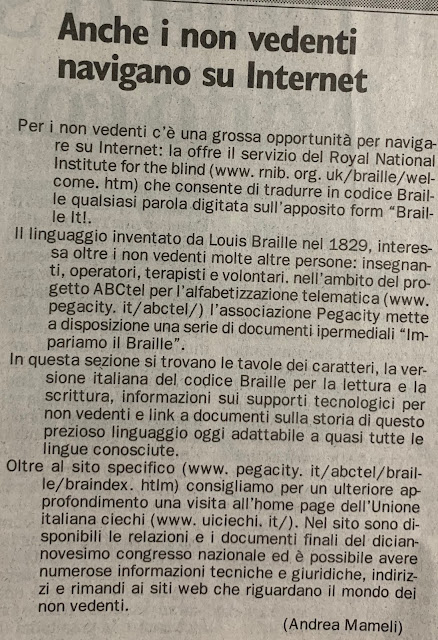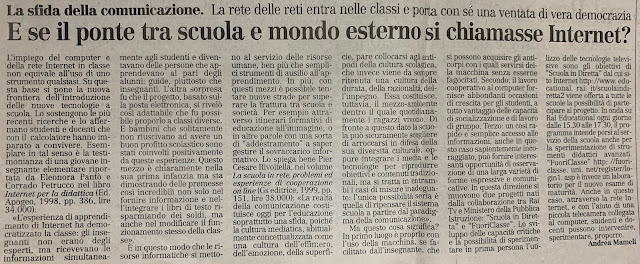L'attrazione fatale della gravità (L'Unione della Scuola, 23 aprile 2000)

Fu la fantascienza, per la precisione con le prime puntate di "Star Trek", che il grande pubblico si avvicinò a uno dei più impegnativi concetti della scienza moderna: il cosiddetto buco nero. Era il 1967. Solo gli addetti ai lavori sapevano che appena quattro anni prima il matematico neozelandelandese Roy Patrick Kerr aveva annunciato la soluzione delle equazioni di Schwarzschild. Di cosa si tratta? In base alle leggi di Newton le orbite intorno ai corpi sferici descrivono traiettorie ellittiche. La teoria di Albert Einstein aggiunge un nuovo elemento, la curvatura dello spazio, descritta dalle equazioni di Karl Schwarzschild, la cui soluzione, dovuta appunto a Kerr, ha acquistato un'importanza straordinaria perché descrive le distorsioni dello spazio e del tempo attorno ad ogni buco nero. Ma cos'è il buco nero? Essenzialmente si tratta dello stadio finale dell'evoluzione di una stella, di massa almeno tripla di quella del Sole, ridotta a dimensioni minime dal co...