Cacciari e Tagliagambe presentano Aresu. Cagliari, 24 Marzo 2007
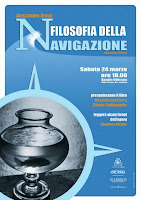
Il libro di Alessandro Aresu, Filosofia della navigazione (Bompiani) , sarà presentato il 24 Marzo alle 18 allo Spazio Odissea in viale Trieste 84 a Cagliari. Presenti con l'autore: Silvano Tagliagambe (docente di filosofia della scienza all'Università di Sassari, Facoltà di Architettura, Alghero) e Massimo Cacciari (filosofo e Sindaco di Venezia). La mattina del 24 Marzo Cacciari ha presentato il libro di Tagliagambe, Leggere Florenskij (Bompiani), evidenizando l'importanza del filosofo (nonché scienziato, teologo russo nel panorama culturale europeo.) Maestri e allievi in mezzo alle onde. Massimo Cacciari dialoga con Alessandro Aresu (L'Unione Sarda, 22 Marzo 2007) Pavel Aleksandrovic Florenskij


