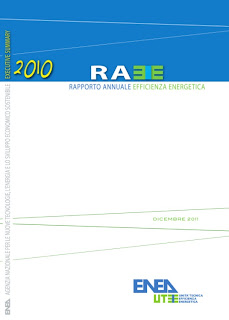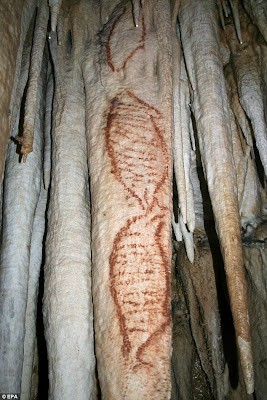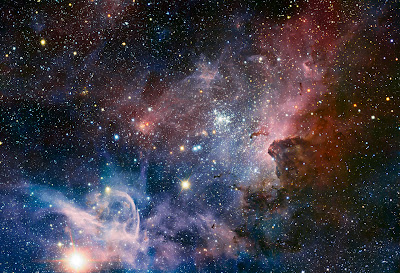L’alfabeto della scienza. Bando per la quinta edizione del Cagliari FestivalScienza

Cagliari FestivalScienza, Quinta Edizione: L’alfabeto della scienza . Modulo di partecipazione da compilare online (è consentito inserire non più di due proposte). Scadenza: 15 marzo 2012 . Le proposte saranno selezionate sulla base di criteri qualitativi e di originalità, autorevolezza, pertinenza rispetto al tema generale oltre che di economicità. La comunicazione dell'eventuale inserimento nel programma del Cagliari FestivalScienza verrà data entro la fine del mese di aprile 2012. L'accettazione non comporta una copertura dei costi della singola proposta: il festival mette a disposizione le strutture, l’organizzazione complessiva e, solo eccezionalmente, eventuali rimborsi per spese vive di viaggio, vitto e alloggio che dovranno essere preventivamente concordate e successivamente documentate unicamente con fatture o ricevute fiscali (non saranno rimborsate le spese documentate da scontrini fiscali). L’accettazione non comporta una copertura assicurativa dei materiali ne’ p...