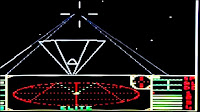Dye-sensitized solar cells are close to break a new record, Michael Grätzel said at the conference "Energy from the Sun" (Chia, Sardinia Island).

Yesterday at the conference "Energy from the Sun: Computational Chemists and Physicists Take up the Challenge" (Chia, Sardinia Island) Michael Grätzel (Director of the Laboratory of Photonics and Interfaces at Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, Switzerland) announced that we are close to break a new record for the dye-sensitized solar cells , after the well-known efficiencies value (12.3%) that appeared in the November 4 issue of Science magazine: Porphyrin-Sensitized Solar Cells with Cobalt (II/III)–Based Redox Electrolyte Exceed 12 Percent Efficiency (Science, Vol. 334 no. 6056 pp. 629-634). This performance is now comparable to silicon-based solar cells that are on the market today. The conference, organized by CECAM (Centre Européen de Calcul Atomique et Moléculaire, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Switzerland) and CNR IOM SLACS (Istituto Officina dei Materiali of CNR, Sardinian Laboratory for Computational Materials Science, University of...