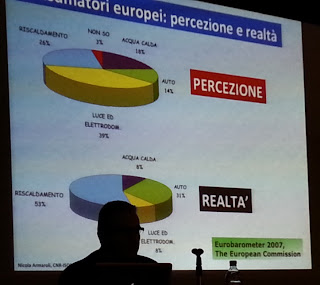L'albero di Foghesu, le foto e la memoria sbiadita

Cosa sarebbe la nostra memoria senza le fotografie ? Sarebbe forse più debole, perché non potrebbe avvalersi di immagini di rinforzo ? Oppure sarebbe più forte, in quanto più allenata a farne a meno? Non ho elementi per analizzare la seconda ipotesi e quindi mi fermo alla prima. Senza le immagini fotografiche alcuni dei nostri ricordi si deformano, sfumano, scompaiono. A volte un ricordo persiste esclusivamente (o quasi) perché viene rigenerato dalle fotografie. Altre volte al ricordo dell’evento si sovrappone al ricordo dalla fotografia dell’evento e l'immagine, stampata o digitale, assume un ruolo cruciale. A me è successo qualcosa di simile con questo autoscatto del 27 Ottobre 1988 (fotocamera reflex: Petri MF-101, obiettivo: 50 mm, pellicola: Kodachrome). Una foto che ha al centro una piccola catasta di legname, a destra, vicino al portone di casa c'è mio padre, Tito, e a sinistra, vicino alla finestra ci sono io. Qualche giorno fa ho ritrovato la foto in un cas...