Le dipendenze sono una condizione di assoluto interesse per chi si cimenta con la neuroetica: rappresentano un paradigma, una sorta di experimentum naturae che esemplifica e amplifica i tratti più rappresentativi delle principali questioni con cui la neuroetica si confronta, come il libero arbitrio, l’autonomia, l’autocontrollo, i processi decisionali, la responsabilità, il conflitto tra ragione ed emozione. Su questo tema non è facile trovare uno spazio di formazione e discussione interdisciplinare tra chi fa ricerca di base e chi lavora in clinica, nelle professioni sanitarie e psicosociali, ma anche per chi si occupa di decisioni e organizzazione delle politiche sulle sostanze psicoattive e della comunicazione sul tema. Intende colmare questa lacuna la Scuola estiva di Neuroetica , giunta alla seconda edizione, organizzata dal Laboratorio Interdisciplinare per le Scienze Naturali e Umanistiche della SISSA , in collaborazione con la Società Italiana Tossicodipendenze ,...


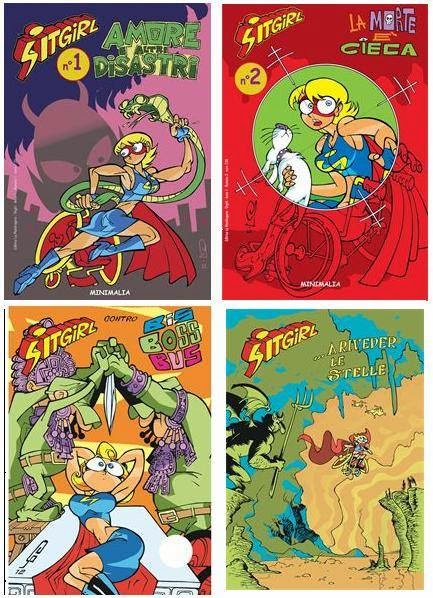

.jpg)

