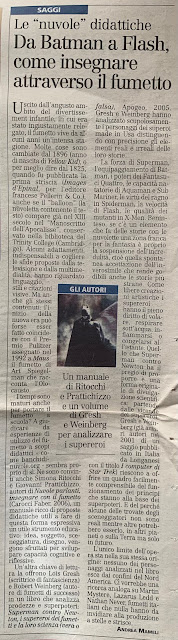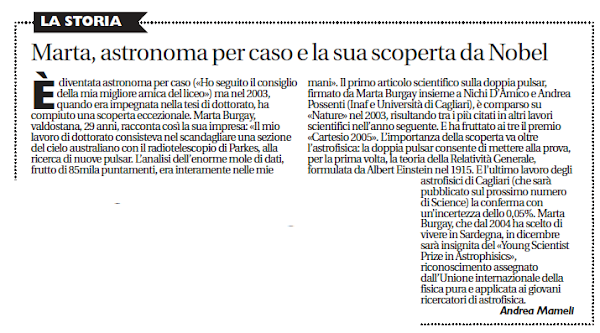Lungo otto sentieri di lettura (L'Unione Sarda, 30 dicembre 2006)

Daniele Barbieri (giornalista, reporter in zone di guerra, attento a temi sociali) e Riccardo Mancini (fondatore della casa editrice Avverbi e presidente del Comitato italiano contro le affermazioni del paranormale del Cicap-Lazio) pubblicano, con la prefazione di Valerio Evangelisti “Di futuri ce n'è tanti. Istruzioni per uscire da un presente senza sogni”. “Di futuri ce n’è tanti” presenta otto sentieri di lettura nella fantascienza, dalle città ai robot, dai computer alle nuove forme del potere, dalla religione al sesso, offrendo letture a volte inedite di un genere per troppo tempo segregato nelle celle della letteratura minore. La fantascienza (science fiction, o Sci-Fi) a torto ritenuta semplice incubatrice di fantasie, a volte premonitrici, in realtà, almeno nella sua fase più matura, dimostra di saper analizzare acutamente anche il tempo presente. Daniele Barbieri e Riccardo Mancini, dopo aver schedato oltre 300 racconti e romanzi del genere, osservano che la vera forza d...